Gli attuali equilibri sociali in Sudtirolo sono retti da due pilastri: la lingua e la residenza.
Il primo pilastro ha la base nella classificazione "etnica" di tutti i residenti in Provincia: a scadenza regolare di alcuni anni, ognuno è invitato a dichiarare la propria appartenenza linguistica (italiana, tedesca o ladina, che sono le tre lingue riconosciute come ufficiali). Il mercato del lavoro pubblico, provinciale o comunale, è quindi regolato dalla cosiddetta proporzionale etnica o, in breve, semplicemente proporzionale; spesso ci si riferisce ad essa anche come la Proporz (ellissi dell'espressione tedesca ethnischer Proporz).
In sostanza, la percentuale di dipendenti pubblici dei vari gruppi linguistici deve rispecchiare fedelmente quella della popolazione totale residente in provincia (per i posti provinciali) o nel comune (per quelli comunali). Ogni bando di concorso pubblico ha pertanto un'indicazione del tipo: "Posto riservato al gruppo linguistico italiano" ("Stelle der italienischen Sprachgruppe vorbehalten"); o tedesco; o ladino.
Ci sono stati pochissimi casi di "ribellione" all'obbligo di dichiarazione etnica: il più noto è quello del politico dei verdi Alexander Langer, che ha platealmente rifiutato di comunicare la sua appartenenza linguistica. Del resto, in Sudtirolo quello dei verdi è l'unico partito dichiaratamente plurilingue e che si batte per una vera integrazione in Alto Adige[1].
Ormai da anni la Proporz è causa di una controversia con l'Unione Europea, in quanto va contro i suoi principi fondamentali: si ammettono classificazioni linguistiche ai soli fini statistici.
Il motore che muove e fa mantenere tutto il sistema della proporzionale è da parte dei tedescofoni la gran paura di essere assimilati e perdere la propria identità (così com'è successo in Venezia Giulia, ove tante sono le persone con cognome slavo, ormai completamente italiane).
Qui in provincia di Bolzano spesso si assiste al fenomeno opposto, con molti che hanno cognome chiaramente italiano, ma nome tedesco, e che sono di madrelingua tedesca sudtirolese. Succede anche l'inverso, anche se, in base alla mia esperienza, più raramente: per esempio, alle elezioni comunali di Bolzano del 2010 due dei candidati italiani di centro-destra si chiamavano Robert Oberrauch e Giorgio Holzmann.
Spesso capita che un ufficio pubblico fatichi a trovare persone valide per ricoprire un posto, sebbene in diversi abbiano le competenze necessarie, in quanto questi appartengono a un gruppo linguistico diverso da quello a cui è riservata la posizione. Esistono norme per derogare alla Proporz, ma tutto il sistema risulta farraginoso, e così può succedere che il lavoro non venga assegnato al più meritevole.
Di recente ho scoperto che anche molti italiani sono favorevoli alla proporzionale poiché si da questa sentono tutelati in comuni a grande maggioranza tedesca: in tali casi si ha la garanzia che alcuni posti pubblici vengano assegnati agli italofoni (pensando che in assenza di norme, invece, un capoufficio di madrelingua tedesca preferirebbe avere tutti dipendenti germanofoni).
La cosa buffa è che cittadini stranieri che non parlano nessuna delle tre lingue riconosciute, devono comunque dichiarare la loro appartenenza ad una di esse. Per esempio, se un finlandese
 viene a vivere qui, all'atto della richiesta di residenza deve dichiararsi tedesco
viene a vivere qui, all'atto della richiesta di residenza deve dichiararsi tedesco
 ,
italiano ,
italiano
 o ladino
o ladino
 (!). Io non me lo immagino proprio un finlandese-ladino
(!). Io non me lo immagino proprio un finlandese-ladino

 [2]!
[2]!
Il sistema proporzionale, tra l'altro, ignora completamente il problema dei mistilingui che rischiano ricadute psicologiche negative, non sentendosi considerati né carne né pesce[3].
Per quanto riguarda il pilastro della residenza, il chiaro obbiettivo dei politici locali è quello di disincentivare l'arrivo di persone in Provincia, soprattutto di nuovi italiani, ed evitare così che si perturbino gli attuali equilibri linguistici. Nel resto d'Italia, di norma almeno qualche aspetto della vita sociale si basa sul domicilio: chi ha intenzione di trasferirsi stabilmente in una certa zona comunica alla questura il proprio indirizzo e acquisisce così alcuni semplici diritti.
Da queste parti, anche dopo aver ottenuto la "cittadinanza sudtirolese", all'inizio non si ha comunque la possibilità di votare nelle elezioni locali (occorre essere residenti in regione Trentino-Alto Adige da almeno quattro anni, di cui la maggior parte in Sudtirolo); in caso di residenza recente, ad ogni consultazione regionale o comunale viene rilasciato un permesso provvisorio per poter votare nel proprio vecchio comune (nel mio caso Genova)!
Inoltre, al non residente vengono negati diversi diritti: dal bollino che dà la facoltà di parcheggiare l'auto nella propria zona (nei posteggi comunque marcati in bianco) alla possibilità di iscrivere i figli negli asili comunali.
Ritornando alla classificazione linguistica, l'episodio più assurdo mi è capitato quando ho dovuto iscrivere all'asilo nido mio figlio (sono residente e posso farlo  ). L'ho messo in lista quando aveva circa quattro mesi: la segretaria che ha ricevuto la domanda mi ha chiesto quale fosse la madrelingua del bambino. ). L'ho messo in lista quando aveva circa quattro mesi: la segretaria che ha ricevuto la domanda mi ha chiesto quale fosse la madrelingua del bambino.
Al che io ho risposto: «Nessuna: non parla ancora!» 
|
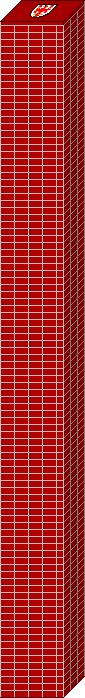
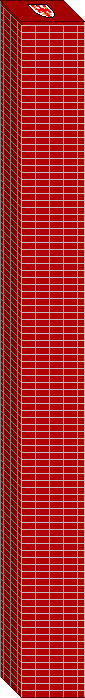
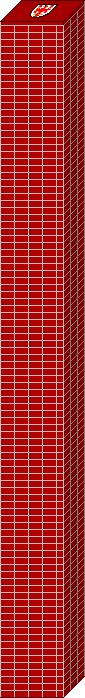
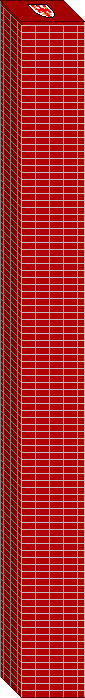
 © 2011, Fabio Vassallo
© 2011, Fabio Vassallo